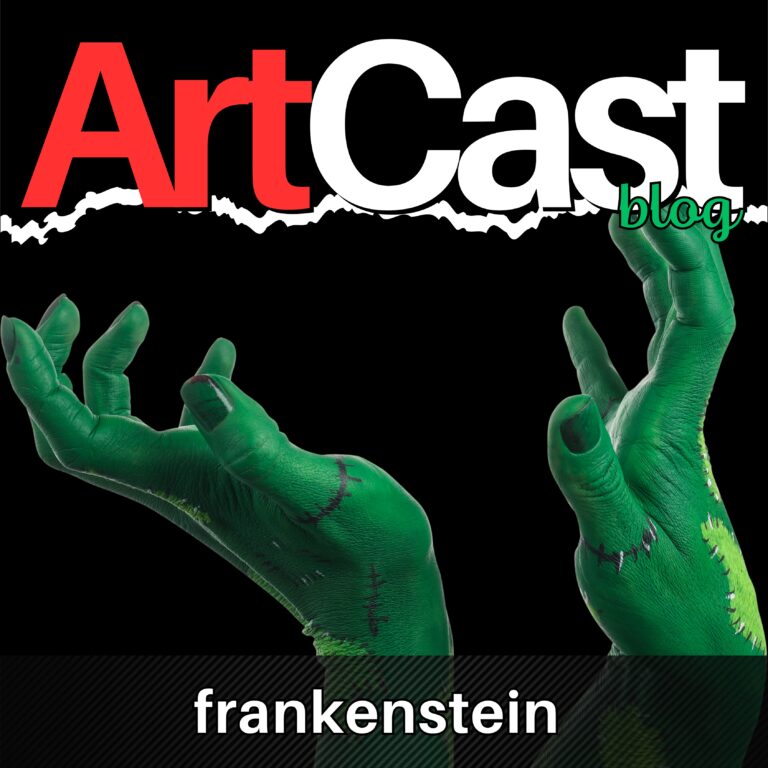Quando Mary Shelley pubblicò Frankenstein, or The Modern Prometheus nel 1818, aveva appena ventun anni. Nessuno, nemmeno lei, poteva immaginare che quel romanzo nato quasi per gioco, durante una notte tempestosa in una villa svizzera, avrebbe dato vita a una delle opere più iconiche della letteratura mondiale e a una creatura destinata a diventare un archetipo universale. La storia di Victor Frankenstein e del suo “mostro” non è solo un racconto gotico, ma un’indagine profonda sull’ambizione, sulla solitudine e sui limiti della conoscenza umana. È una riflessione che attraversa i secoli e continua a interrogare le coscienze, tanto da rendere l’opera di Mary Shelley più attuale che mai. Il romanzo nacque in circostanze che hanno assunto i contorni del mito. Era l’estate del 1816, quella che gli storici ricordano come “l’anno senza estate”, a causa di un’eruzione vulcanica che oscurò i cieli d’Europa. Mary Godwin, allora non ancora sposata con il poeta Percy Bysshe Shelley, si trovava in compagnia di lui, di Lord Byron e del medico John Polidori in una villa sul lago di Ginevra. Le piogge incessanti costringevano il gruppo a restare al chiuso, e Byron propose di scrivere ciascuno una storia di fantasmi per passare il tempo. Fu così che Mary, dopo giorni di silenzio creativo, ebbe un sogno che la scosse profondamente: vide uno scienziato piegato su un essere appena animato, un abominio che si muoveva e la fissava con occhi spalancati. Da quella visione nacque Frankenstein. Pubblicato inizialmente in forma anonima, il romanzo fu accolto con curiosità ma anche con diffidenza. Pochi sospettavano che dietro quelle pagine dense di riflessione scientifica e filosofica si celasse la mano di una giovane donna. Il titolo completo — Frankenstein, or The Modern Prometheus — rivela già il cuore simbolico dell’opera: come Prometeo, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, Victor Frankenstein osa sfidare le leggi naturali creando la vita dal nulla. Ma, come l’eroe mitologico, è punito per la sua hybris, la sua tracotanza. L’orrore non nasce dalla mostruosità della creatura, ma dall’arroganza dell’uomo che vuole essere dio. Mary Shelley scrive un romanzo che mescola la tensione gotica con la riflessione scientifica dell’epoca. Le teorie sull’elettricità e sulla galvanizzazione — esperimenti che sembravano in grado di ridare vita ai tessuti morti — avevano affascinato gli scienziati e alimentato il dibattito sul confine tra vita e morte. Shelley, attenta osservatrice e appassionata di filosofia naturale, trasformò quelle suggestioni in materia narrativa. Ma Frankenstein è anche, e soprattutto, un romanzo profondamente umano. Al centro non c’è solo la creatura, ma la sua disperazione. Il “mostro” non nasce cattivo: impara l’odio solo dopo essere stato rifiutato da tutti, persino dal suo creatore. Cerca amore, accettazione, un posto nel mondo — e quando non li trova, reagisce con rabbia. È una creatura tragica, che riflette la fragilità e il bisogno d’amore insiti nell’uomo. Curiosamente, nel linguaggio comune, il nome “Frankenstein” viene spesso usato per indicare il mostro, quando in realtà è il cognome dello scienziato. Mary Shelley non dà mai un nome alla sua creatura: la chiama “demone”, “abominio”, “figlio dell’inferno”, “creatura”. Questa mancanza di nome è un dettaglio cruciale, un segno della sua condizione di escluso. Non avere un nome significa non avere un’identità, non appartenere a nulla. È la condanna più terribile che un essere vivente possa subire. Il successo di Frankenstein esplose dopo la sua pubblicazione definitiva nel 1831, in una versione rivista e più matura. Da allora il romanzo ha ispirato migliaia di adattamenti teatrali, cinematografici e artistici. Già nel 1823, una versione teatrale intitolata Presumption; or The Fate of Frankenstein conquistò i palcoscenici di Londra, contribuendo a fissare l’immaginario visivo del mostro. Ma fu il cinema a trasformarlo in leggenda. Nel 1931, il regista James Whale portò sullo schermo la celebre versione con Boris Karloff nei panni della creatura, donandogli il volto quadrato, i bulloni al collo e l’andatura incerta che sarebbero diventati simboli universali. Da allora, Frankenstein è diventato un’icona pop, reinterpretato in chiave horror, satirica, filosofica e perfino comica. Dietro il successo e la fama, tuttavia, resta il messaggio profondo di Mary Shelley: la responsabilità morale della scienza e il destino di chi crea senza compassione. In un’epoca in cui la tecnologia avanza a ritmi vertiginosi, il romanzo conserva un’attualità inquietante. Frankenstein rappresenta la tensione eterna tra curiosità e limite, tra progresso e etica. È la storia di un uomo che, nel tentativo di vincere la morte, genera la sua stessa rovina. Un aspetto poco noto riguarda il tono intimo e autobiografico dell’opera. Mary Shelley aveva conosciuto da vicino la perdita: la madre, la filosofa Mary Wollstonecraft, era morta poco dopo averla messa al mondo, e anche lei avrebbe perso diversi figli in tenera età. La creazione e la morte erano per lei esperienze vissute nel profondo. Scrivere Frankenstein significava anche dare voce a un dolore personale, trasformare la sofferenza in creazione artistica. Forse, nel dare vita alla sua creatura, Mary stava anche cercando di ridare vita a ciò che aveva perduto. Oltre al suo valore letterario, Frankenstein può essere considerato il primo romanzo di fantascienza della storia. Mary Shelley anticipa temi che diventeranno centrali nel secolo successivo: la scienza come potere, l’intelligenza artificiale, il confine tra uomo e macchina, la responsabilità della creazione. La sua visione, così moderna e profetica, ha ispirato scrittori, filosofi e registi di ogni epoca. A più di due secoli dalla sua pubblicazione, Frankenstein continua a parlare al cuore e alla mente dei lettori. È un’opera che non invecchia, perché racconta paure e desideri che restano immutati: il sogno di dominare la vita, la paura di perdere l’umanità, la necessità di essere amati. Nel suo laboratorio oscuro, Victor Frankenstein accende una scintilla che ancora oggi illumina le zone più profonde dell’animo umano. Mary Shelley, con la forza visionaria della giovinezza e il coraggio della sensibilità, ha creato non solo un mostro, ma un simbolo eterno dell’uomo che osa sfidare se stesso.
Posted inBLOG
FRANKENSTEIN