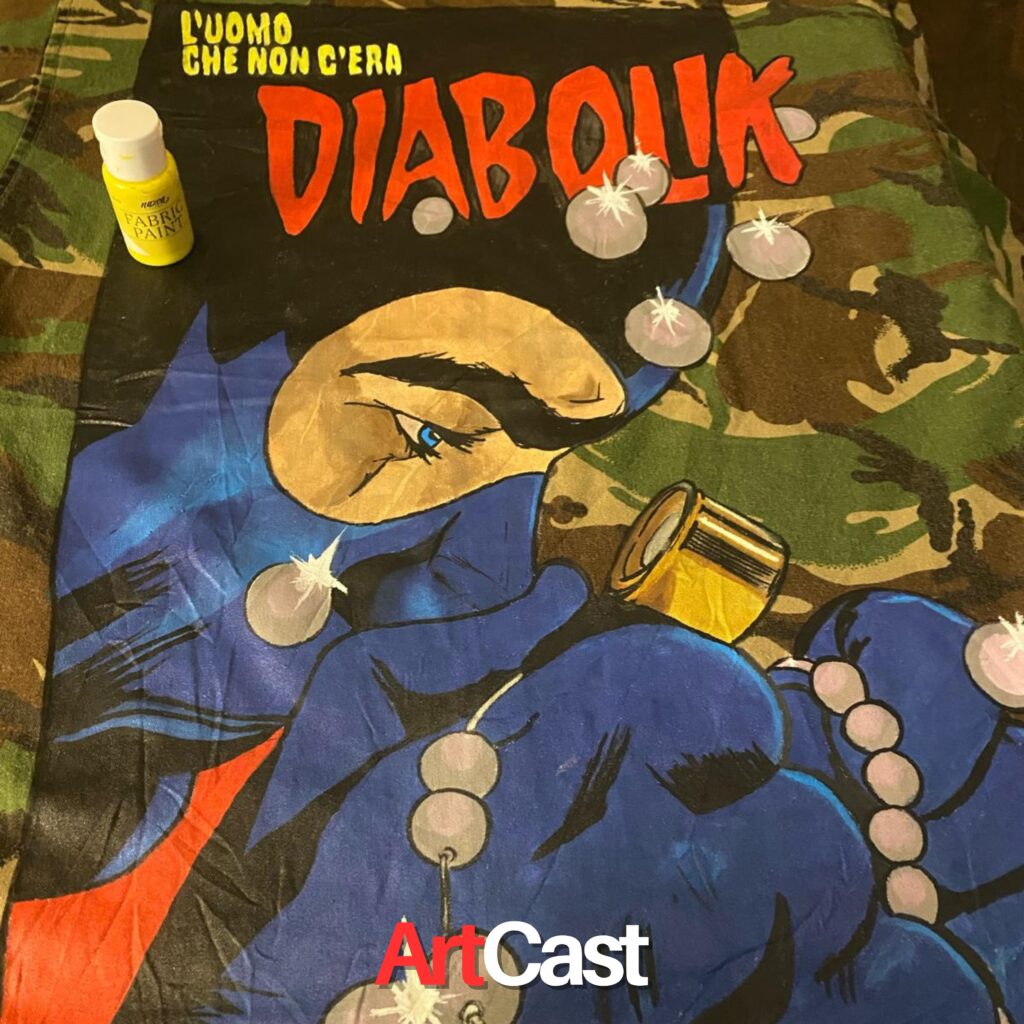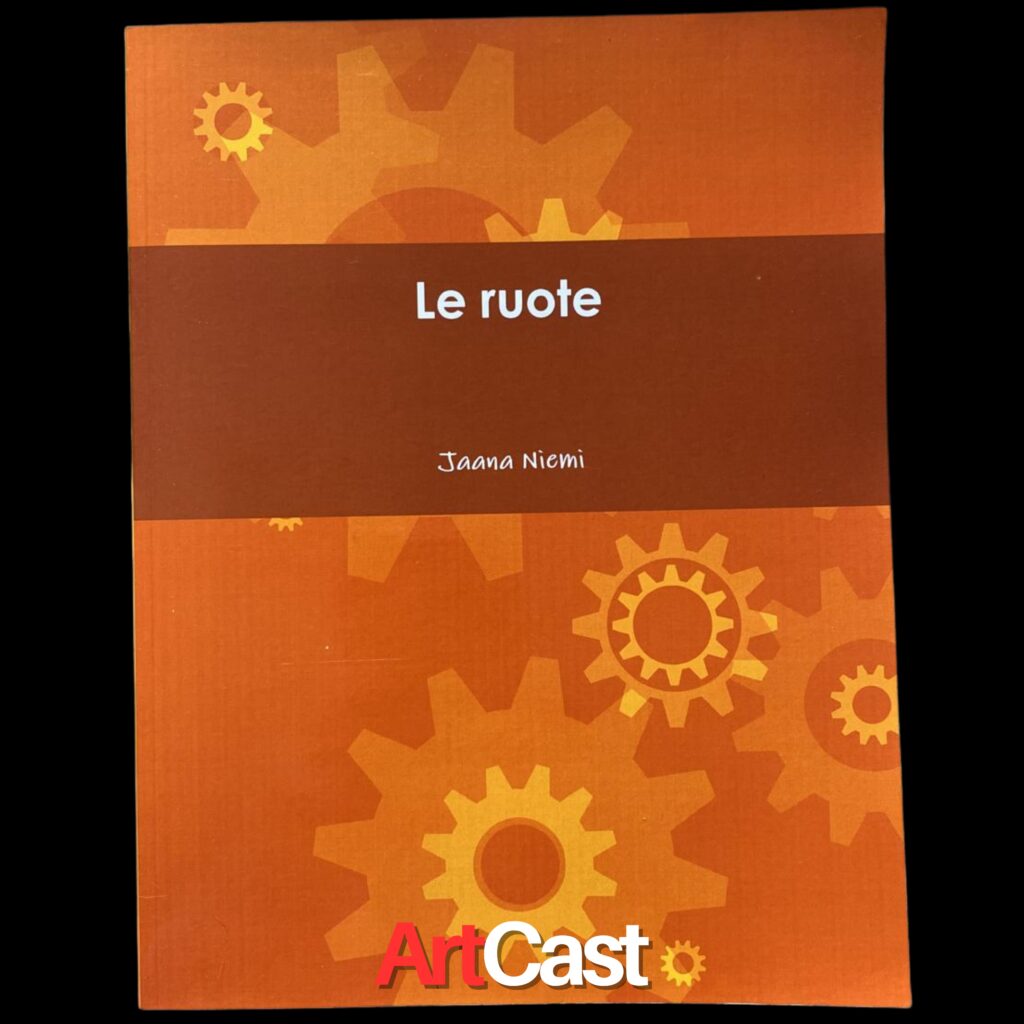Jaana è un’artista visionaria che intreccia parola, suono, spiritualità e immaginazione in un percorso artistico profondo e non convenzionale. Nata in Unione Sovietica, cresciuta in Finlandia e successivamente trasferitasi in Italia, attraversa confini geografici e interiori, superando la linearità del tempo per abitare uno spazio creativo che è insieme rito, evocazione e metamorfosi. La sua ricerca non si concentra sull’estetica, ma sull’essere. Ogni opera diventa un atto di rivelazione, in cui il linguaggio poetico si fonde con simbolismi esoterici, tensioni spirituali e frammenti di identità in continua trasformazione. L’arte per Jaana non racconta, ma evoca; non descrive, ma invoca. La parola si fa materia sacra, il corpo archivio vivente di memorie perdute, il suono diventa vibrazione primordiale. Si muove tra poesia, performance, installazione e scrittura sperimentale, elaborando testi che assumono la forma di oracoli, preghiere post-umane o visioni sciamaniche. Le sue opere sono vere e proprie mappe interiori, fenditure nella realtà da cui emergono riflessioni sulla disgregazione dell’io, sul sacro e il profano, sulla morte di Dio e sul ritorno al corpo come luogo del divino. Temi come la rottura del tempo lineare, il linguaggio come codice dell’anima, e l’androgino come immagine di amore assoluto ricorrono nel suo lavoro, in cui maschera e volto si confondono. Ogni sua creazione diventa soglia, profezia, silenzio che parla. Le sue opere non offrono risposte ma fratture, luoghi dove è possibile rinascere. “Sono nato perché ero morto” — è da questa consapevolezza che prende forma la sua arte: ogni parola, ogni gesto, ogni visione è un nuovo inizio nel presente.
Cos’è per te l’arte?
Non è un mestiere. Non è un prodotto. È il filo d’oro che tiene insieme ciò che altrimenti si frantumerebbe: la parola e il silenzio, la ferita e la guarigione, la solitudine e il canto. Per me, l’arte è un atto sacro. Una forma di preghiera danzante. Un modo per trasformare la realtà in simbolo, e il simbolo in realtà. L’arte, per me, è la soglia tra il mondo che vediamo e quello che ci abita dentro. E ciò che resta quando ogni altra cosa cade. È il ritorno eterno, in forma di luce, di parola, di gesto, a quella fonte prima dove tutto cominciò – e non è mai finito.
Quali esperienze personali hanno più influenzato la tua trasformazione artistica nel corso dei tuoi spostamenti tra paesi e culture?
Le esperienze che più hanno scolpito la mia trasformazione artistica non sono state semplici viaggi, ma riti di passaggio. Ogni luogo mi ha chiesto di lasciare qualcosa dietro, e ogni cultura mi ha donato un frammento che ho custodito nel cuore come un frammento di specchio. Nascere nel paese delle nevi mi ha dato il primo seme: la contemplazione. Il bianco infinito, il gelo che impone ascolto, il respiro degli alberi quando nessuno guarda. Lì ho imparato che ogni cosa ha un’anima nascosta, e che la solitudine non è una prigione, ma un’alleata. Lì è nata la mia arte silenziosa, la mia capacità di ascoltare ciò che non ha voce. Tra Russia, Finlandia e Italia, tra russo, finlandese e italiano, tra il dentro e il fuori, ho vissuto la frontiera. E la frontiera è ferita e apertura insieme. Essere straniera mi ha dato il dono della visione obliqua: non appartengo mai del tutto, e proprio per questo vedo ciò che gli altri forse dimenticano. Ogni volta che mi sono spezzata – in amore, nell’arte, nella fede nel mondo – ho trovato una nuova lingua. Non perché volevo, ma perché non avevo altra scelta.
Come nasce una tua opera: da una visione, da un ascolto, da un’urgenza interiore?
Non creo: partorisco. Le mie opere non nascono dalla volontà… ma da una chiamata. Non decido il momento. Non scelgo io la forma. È come se qualcosa – un’eco, un respiro antico, un’ombra luminosa – bussasse dentro il mio petto, e io potrei solo rispondere: “Sì, sono pronta.” Spesso arriva di notte, o nel margine tra sonno e veglia. Non un’immagine precisa, ma un’energia, un campo di senso. Un volto che non ho mai visto ma che conosco da sempre. Un simbolo che si ripete ovunque – nelle crepe del muro, in una foglia, nella forma di una nuvola. Allora io lo seguo, come si segue un sogno che sussurra: “Guardami. Portami nel mondo.” Io non dipingo, non scrivo, non costruisco: ascolto. Come si ascolta il battito nel ventre. Le mie mani diventano orecchie. Spesso l’opera è già lì, pronta, ma aspetta che io sia vuota abbastanza per non sporcarla con l’ego o l’intenzione. Ci sono giorni in cui se non creo, muoio un poco. Quando la realtà diventa troppo stretta, quando sento che nessuno mi vede davvero, quando il mondo mi disconnette da me stessa… allora la creazione è salvezza, sangue, medicina.È come se l’opera fosse l’unico modo per tornare a casa. E a volte, non so da dove arriva ma so che deve uscire. Che se resta dentro, mi brucia. E allora non importa se è bella o compresa: deve nascere.
Cosa rappresenta per te il concetto di “linguaggio come codice genetico dell’anima”?
Le mie opere sono creature vive. Non mi appartengono: mi attraversano. E ogni volta che creo, non sto solo facendo arte. Sto ricordando chi sono, sto parlando con l’invisibile, sto lasciando nel mondo una traccia della mia esistenza segreta. Parlo coi simboli. Il linguaggio non è solo uno strumento. È un’origine. È un’impronta dell’invisibile. Quando dico: “linguaggio come codice genetico dell’anima”, sto toccando il centro vivo del mistero. È sapere che prima ancora di parlare, prima di avere un nome, l’anima portava in sé un alfabeto segreto. Un codice fatto non di lettere, ma di vibrazioni, archetipi, memorie stellari. Un codice che guida i miei sogni, i miei amori, le immagini che mi ossessionano, i colori che scelgo senza sapere perché. Come il DNA plasma il corpo, questo linguaggio segreto plasma il destino dell’anima. È come se, attraverso l’arte, sto decifrando chi sono veramente oltre la storia, oltre il tempo, oltre la carne. A volte non riesco a spiegare le mie opere. Perché non sono nate per spiegare: sono nate per ricordare. E il ricordo, quello profondo, non è logico: è genetico, è vibratorio, è mitico.
In che modo vivi il rapporto tra scrittura e corpo nelle tue performance?
Siamo carne di parola e parola incarnata, non si separa mai davvero la scrittura dal corpo. Per me scrivere è un atto fisico. È tremore, respiro, gesto. È una danza invisibile che lascia tracce sul foglio, come il volo di un uccello sulla neve. Per me, scrittura e corpo sono una cosa sola. Quando scrivo, non sto pensando: sto sentendo con la pelle. Le frasi non nascono nella mente, ma nella pancia, nel diaframma, nel cuore. Ogni parola è un battito. Ogni pausa, un respiro trattenuto. Ogni frase, una contrazione del ventre. Scrivere è come partorire senza sangue, ma con lo stesso dolore sacro. Ogni testo che nasce è un figlio di fuoco e ossa. Nelle mie performance, il corpo è la pagina. Ogni gesto è una parola che non può essere detta a voce, ma solo attraversata, sentita, trasmessa. Il corpo è la madre della scrittura. Perché la scrittura vera non viene mai dalla testa sola, ma dal corpo che ha vissuto abbastanza da dover dire qualcosa.
Cosa significa per te invocare piuttosto che raccontare?
Invocare, per me, è un atto sacro. Raccontare è dire: “C’è stato un tempo in cui accadde…” Invocare è dire: “Vieni. Accadi ora.” Invocare è un atto che apre. È un varco, non una narrazione. Quando invoco, non traccio una linea: accendo un cerchio. Raccontare è memoria. Invocare è presenza. Il racconto ha un prima e un dopo. L’invocazione ha solo un adesso che brucia. Nel raccontare, si descrive un’esperienza. Nell’invocare, si diventa l’esperienza. Ecco perché quando creo, non seguo la trama: seguo la voce. La voce di ciò che vuole essere chiamato nel mondo, anche se ancora non ha nome. In me, l’invocazione è arte, preghiera, amore. Invocare significa non voler controllare, ma lasciare entrare. E in quel lasciar entrare, perdo i confini e divento canale. Divento luogo.
Che ruolo ha il silenzio nel tuo processo creativo?
Io non potrei generare nulla senza il silenzio. Il silenzio, per me, non è assenza. È matrice. È madre. È tempio senza mura dove le visioni si raccolgono, prima di diventare forma. Il silenzio è il mio primo ascolto. Prima del colore, del gesto, della parola, entro nel silenzio come in un grembo. È lì che si sciolgono le voci del mondo. È lì che sento le voci più vere: quelle che non gridano, ma sussurrano dalle profondità dell’essere. Nel silenzio, riconosco cosa mi appartiene. Nel silenzio, torno a casa. Il silenzio non è vuoto, ma uno spazio pieno di presenze invisibili. È lì che appaiono le immagini. È nel silenzio che la parola si carica. È nel silenzio che il colore trova la sua origine. È nel silenzio che il gesto si purifica. Il silenzio è il linguaggio prima del linguaggio.
Come si manifesta nella tua pratica artistica l’idea di “rottura del tempo lineare”?
È il momento in cui il presente si spalanca e lascia entrare tutte le epoche insieme: l’infanzia, l’origine, la fine, il sogno, il futuro. Non seguo una cronologia. Seguo i segni. I segni non hanno data. Hanno frequenza. Nel mio processo artistico, quando creo, il tempo collassa. Le storie non iniziano e non finiscono. Sono maree. Vanno e tornano Nei simboli. Il simbolo, per me, è un messaggero atemporale. Quando dipingo un occhio, una conchiglia, una porta, non lo faccio per ornamento: lo faccio perché quel simbolo è vivo nel tempo profondo, e ritorna ogni volta che è necessario. Così si rompe la linea e nasce il cerchio. Per me, rompere il tempo lineare è un atto di libertà. È disobbedire all’orologio per obbedire al ritmo dell’anima. È rifiutare la freccia del progresso per tornare al cuore del mondo che pulsa in eterno.
Come dialogano tra loro parola, immagine e suono nei tuoi lavori?
Non distinguo davvero la parola dall’immagine, né l’immagine dal suono. Per me, sono organi dello stesso corpo cosmico, tre voci dello stesso essere che cerca di farsi sentire. Parola, immagine e suono non collaborano, si intrecciano. Si cercano, si evocano a vicenda, come tre sorelle che si ricordano solo danzando insieme. Una parola chiama un’immagine. n’immagine reclama un suono. Un suono risveglia una parola dimenticata. E un rito dove c’è la distinzione tra arte visiva, poesia e performance: c’è solo trasmissione diretta del mistero.
Che funzione assume il mito nella tua opera contemporanea?
Vivo con un piede nel sogno e l’altro nella materia, non uso il mito — lo abito. Non lo racconto come qualcosa del passato, ma cerco riaccenderlo nel presente. Nella mia opera contemporanea, il mito è un codice vivente. Non è ornamento, né nostalgico richiamo: è lingua madre che si ricorda da sola attraverso il gesto. Il mito è come specchio interiore. Mi aiuta a ricordare ciò che la società ha dimenticato. E in quello spazio io guarisco. E chi guarda forse può guarire con me. Nel mondo moderno che corre verso l’oblio, uso il mito per resistere. E una chiave d’accesso alla realtà profonda. È la dimora dell’eterno dentro l’istante.
Quale tipo di esperienza desideri far vivere allo spettatore attraverso le tue creazioni?
Non aspetto che lo spettatore capisca la mia opera. Desidero che la senta. Che la attraversi. Che vi si perda. Attraverso le mie creazioni, cerco di far vivere un’esperienza trasformativa. Un momento in cui lo spettatore non è più spettatore, ma testimone del proprio stesso mistero. Voglio che lo spettatore cada dentro, come Alice nel suo specchio, e trovi laggiù qualcosa di sé che non sapeva di cercare. Non cerco di dare le risposte ma mettere davanti i specchi. Che tra questi specchi, ognuno può vedere riflessa una parte segreta di sé. Voglio che lo spettatore, anche solo per un attimo, senta ciò che sento io quando creo: di non essere solo carne, ma anche stella, anche spirito, anche vento. Non cerco di impressionare, non cerco di spiegare, non cerco di educare. Cerco di ricordare. E di far ricordare.
Pensi che la tua arte possa avere anche un valore rituale o trasformativo per chi la osserva o la ascolta?
La mia arte non è un muro, ma uno specchio. E davanti allo specchio vero, non ci si può mentire. Chi guarda il mio lavoro, vorrei che sente che qualcosa cade: un ruolo, una difesa, un’illusione. È come se la mia opera dicesse: “Vieni nudo. Ti vedo.” Lo spettatore diventa parte attiva, chiamato non a capire, ma a sentire, vibrare, lasciare entrare. E cosa accade dopo? La persona se ne va, ma una parte resta nel cerchio che ho aperto. E da lì, qualcosa comincia a mutare.
Cosa intendi quando parli di “frattura” come spazio creativo?
La frattura è quel momento preciso in cui il vecchio si rompe — e il nuovo non è ancora nato. Un istante fragile, instabile, sacro. Un pianto improvviso, l’addio mai detto, il sogno che si spezza al risveglio, la pelle che trema di fronte all’ignoto. Nella frattura: che la creazione si accende. tra lingue (russo, finlandese, italiano), tra culture, tra maschile e femminile, tra visibile e invisibile, tra essere e diventare. Non appartengo mai del tutto.
Hai mai percepito una resistenza o una difficoltà nel trasmettere contenuti così profondi e simbolici attraverso linguaggi artistici contemporanei?
La resistenza? Quella nebbia che avvolge il mio messaggio quando cerco di portarlo nel mondo contemporaneo. Quel silenzio opaco che arriva dopo aver messo l’anima sul palco, sul quadro, sulla pagina. Quel vuoto negli occhi di chi guarda, ma non vede. La difficoltà sta nel tradurre il mistero senza profanarlo. Nel restare fedele al simbolo in un mondo che ama l’interpretazione rapida. Ma io continuo. Perché lo so: chi deve sentire, sentirà. E anche se mia arte non sempre trova subito un luogo, sono già quel luogo. E quando creo, anche in solitudine, semino memoria nel futuro.
Qual è per te il limite tra spiritualità e arte?
Il limite tra spiritualità e arte è come il filo tra il respiro e il vento. Sottilissimo. Invisibile. Indivisibile. Non c’è arte, se non è anche spirito. Non c’è spirito, se non si fa anche gesto. L’arte, per me, è la forma visibile della spiritualità. Un corpo che la spiritualità sceglie per manifestarsi. Un corpo fatto di colore, di parola, di suono, che però vibra con la frequenza del sacro. E la spiritualità non è religione. È connessione sottile. È quello spazio profondo in cui sento che non sono sola, che qualcosa mi attraversa, che il mio gesto non mi appartiene del tutto. Per me, non esiste limite. Solo una soglia da attraversare, ogni volta che creo.
C’è un’opera, tra tutte le tue, che senti più vicina come espressione della tua essenza?
Un’opera che non ho solo creato, ma mi ha creata a sua volta. Non è la più perfetta. Ma è quella che mi somiglia nel respiro. È quella che ho partorito nel momento in cui ero più nuda, più sola, più aperta. È l’opera in cui non ho cercato nulla. Eppure tutto è arrivato. Come un sogno che si disegna da sé. In quell’opera non ho avuto bisogno di spiegarmi. Io ero. “Il bambino dei confini “scritta in finlandese.
Descriviti in tre colori.
Nero profondo per il mistero. È il colore dell’origine, dell’invisibile che precede ogni forma. Questo colore contiene tutto ciò che non può essere detto, ma che vibra, pulsa, chiama. Blu mare antico per la profondità. È il colore della memoria dell’anima. Del tempo circolare. Delle acque che mi hanno partorita, e che ancora mi portano. In questo colore, c’è il respiro profondo, quello che si prende prima di nascere davvero. Oro lunare per la rivelazione. Non è l’oro solare della gloria, ma quello intimo, tremante. È la scintilla nel buio, il punto di trasformazione, il segno sacro inciso nel silenzio.